6 Maggio 2016
Con Christoph Radl non abbiamo parlato solo di design e moda, capitalismo e democrazia, Milano ed Ettore Sottsass. Durante l’intervista, in realtà due, registrate un sabato mattina nel suo studio a due passi dal Duomo, abbiamo discusso anche di altro. Davanti a caffè e brioche abbiamo parlato anche di droga. Nel senso hippie del termine (se così si può dire). Christoph Radl nasce in Svizzera e cresce in Austria. Arriva a Milano negli anni Settanta, per frequentare la Scuola Politecnica di Design. Si occupa di grafica quando essere grafici vuole dire disegnare un carattere Bodoni con la china, il compasso e i pennelli. Conosce Ettore Sottsass negli anni Ottanta, disegna l’immagine di Memphis, e nel 1984 fonda l’agenzia Italiana di Comunicazione. Nel 1993 avvia lo studio di art direction, comunicazione e graphic design R.A.D.L.&. Lavora per Armani, Ferragamo, Pucci e Trussardi, fa campagne per Alessi, Cassina, Magis, Sony, Zanotta, realizza iniziative editoriali con gallerie e fondazioni: da Palazzo Grassi al Museum of Contemporary Art di Chicago, dal Guggenheim di Bilbao alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino. È stato per quindici anni art director di Interni e di recente ha progettato Grazia Casa, Anew e Cabana. Oggi è art director di AD, sta lavorando a un libro per Dior e a una monografia sull’artista cinese Yan Pei-Ming per Rizzoli International.
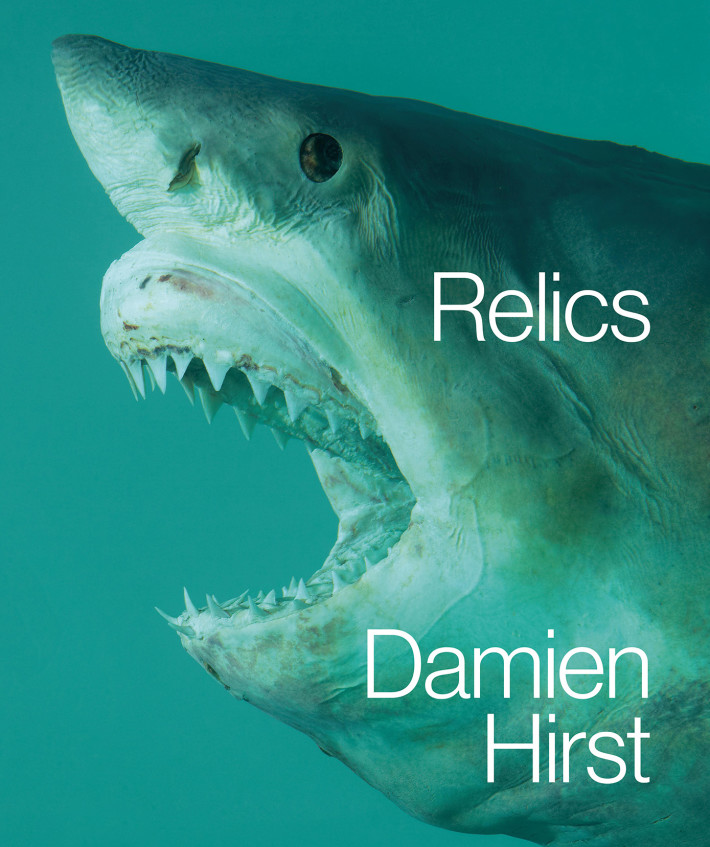
Catalogo Relics, Damien Hirst, 2013. Cover.
Quando sei arrivato a Milano?
La prima volta è stata nel 1972, quando con un amico tedesco producevo giacchette di carta per andare in bicicletta. Erano serigrafate, personalizzabili, e le vendevamo sia in un night club della città, che le regalava ai suoi clienti, sia in alcune boutique tirolesi. Per produrle avevo scelto Milano perché c’era la sede della prima azienda specializzata in questo tipo di indumenti. Inoltre, in città abitava anche mia sorella, che faceva la modella. Volevo frequentare una scuola e mi decisi per la Politecnica, che ai miei occhi aveva un unico grandissimo pregio: durava solo un anno, trascorso il quale sarei andato a New York.
Ma non sei più ripartito. Della Milano di allora cosa resta?
Resta una certa qualità della vita, e i rapporti umani così diversi dai Paesi nordici e anglosassoni. A Milano, il mio negozio di frutta e verdura è anche un luogo di amicizia, di incontro e di confronto.
Ti è mai venuta un’idea dal fruttivendolo?
Di solito non mi accorgo quando mi vengono le idee, credo che i pensieri siano un flusso costante. Le idee vanno provocate, non esistono illuminazioni. Io, poi, faccio solamente il grafico. Lavoro su commissione, non sono un artista.

Catalogo Magis/MeToo, 2005.
Però converrai che si tratta di un mestiere creativo.
Vero. Se ho un problema da risolvere, cerco l’idea.
E al nord non la trovi?
È diverso. A Vienna sono andato in una rosticceria per comprare del prosciutto, ho fatto una battuta e tutti mi hanno guardato male. A Milano non è così, la gente interagisce, è tutto molto italiano.
Come lavori?
Instauro un rapporto umano con la committenza, anche se con le strutture più organizzate può essere molto difficile.
Cosa fai più volentieri fra design, arte e moda?
Dipende. Lavorare con un artista o con un curatore è ben diverso dal produrre una brochure. Magis, per esempio, è un’azienda eccezionale e la cosa che più mi divertiva era il rapporto che avevo con il carismatico imprenditore Eugenio Perazza.
Fra le tante cose che hai fatto, mi incuriosisce la rivista Cabana.
È un progetto editoriale a cui tengo molto. Abbiamo anche organizzato una festa a Londra qualche tempo fa, in uno studio fotografico che sembrava un set per il cinema. È andata molto bene. Alle pareti abbiamo messo la nostra carta da parati prodotta da Dedar. Sono contento soprattutto perché Cabana sta suscitando un grande entusiasmo nel mondo anglosassone.
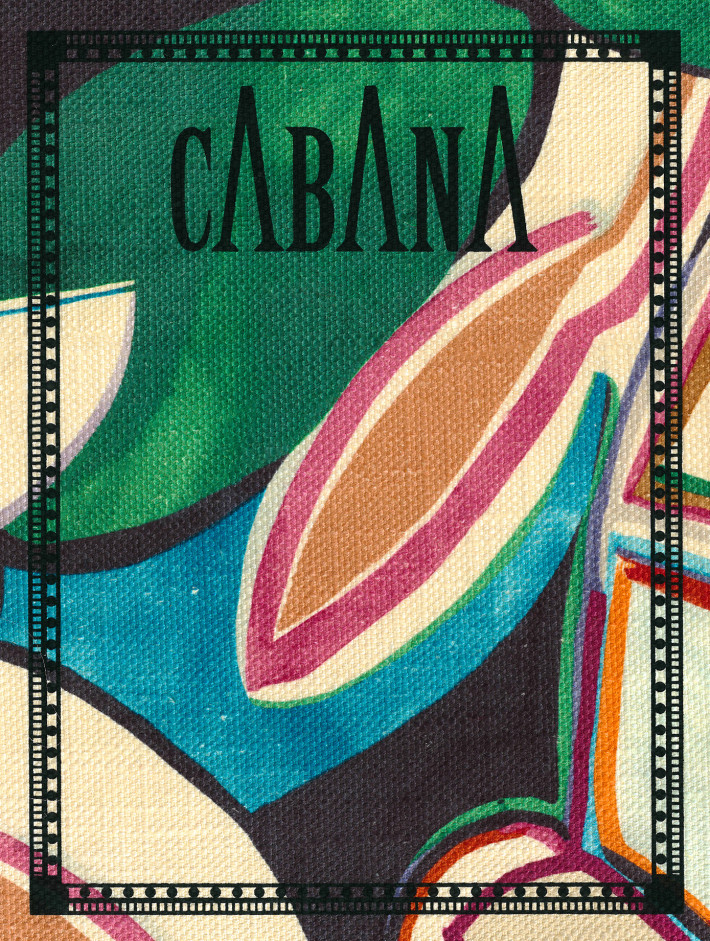
Cabana Magazine, n. 4, ottobre 2015. Cover.
Su Cabana ho visto una tua intervista ad Andrea Branzi. Parli dei tempi di Memphis e dici che è stato l’inizio della fine del design. Addirittura?
Quando parlo di fine del design intendo la fine di un ruolo di arricchimento culturale e sociale. Il design è nato con l’avvento dell’industrializzazione, l’ultimo creativo che ha unito arte e design è stato Gio Ponti. Lui faceva decorare contenitori di ceramica, il contenitore era un prodotto industriale, ma la decorazione era realizzata a mano. Questo tipo di artigianato è sparito con l’idea che prodotti sempre più belli e accessibili avrebbero arricchito la vita della gente comune. Si sarebbe potuto vivere in case più pulite, meglio disegnate e sempre più funzionali.
Poi cos’è successo?
Si è andati avanti finché il funzionalismo ha rivelato tutta la sua debolezza, perché aveva annullato il significato emotivo dell’oggetto come depositario di affetto, di culto, di tratti sciamanici. Il radical design, Memphis e anche Alchimia, hanno voluto restituire all’oggetto la sua dimensione emozionale ed esistenziale, carica di un forte elemento decorativo. Oggi l’unica cosa che posso dire è che il design non è più un’arte.
E allora cos’è?
Un mestiere, come l’avvocato o il dentista. Oggi il design è principalmente la capacità di interpretare le informazioni di marketing e di tradurle nella forma migliore, al prezzo migliore. Si cerca di disegnare una certa sedia per un dato ambiente, ma quest’attività non ha nulla di artistico.
Potremmo dire che l’esecrabile fame dell’oro ha conquistato il cuore dei designer, parafrasando Virgilio.
Non c’entra il denaro, credo semplicemente che si sia esaurita la funzione storica del design come forma d’arte.
Da cosa viene riempito questo spazio vuoto?
Forse è meglio distinguere. Una parte del design è ancora vitale, quello che fa Branzi è design, ma è anche arte, come nel caso di Studio Job o di Martino Gamper. Ma Antonio Citterio, per esempio, non pensa minimamente di fare arte, fa un mestiere e lo fa molto bene.
Ed Ettore Sottsass?
Esaurito il suo ciclo, Memphis era praticamente svanito, dimenticato. Da un paio d’anni, invece, il mondo della moda lo ha riscoperto come fonte di ispirazione. Continuo a ricevere telefonate di studenti che vogliono avere informazioni su Sottsass, su Memphis e sulla grafica di quegli anni.
Puoi comunicarle ora, per tutti quelli che ti chiameranno in futuro.
Da grafico, il mio contributo è stato quello di assemblare in forma coerente, con cataloghi, poster e tutto il resto, la produzione di Memphis. Ma a questo punto bisognerebbe definire cos’è la grafica.

Memphis, Texture, Abet Laminati, 1982.
Definiamola.
Oggi si è imposta la grafica applicata (cartoline, website, etc.), mentre in Memphis la grafica era decorativa. Come i famosi laminati di Sottsass, di De Lucchi o miei, per non parlare di quell’incredibile fiume creativo che era Nathalie du Pasquier. Quando pensi a Memphis, l’ultima cosa che ti viene in mente sono i cataloghi, tutti si ricordano dei mobili di Nathalie du Pasquier e di Sottsass.
Com’era Sottsass?
Era un austriaco.
Il suo cognome dice tutto: Sotto al sasso. Com’è iniziata la vostra collaborazione professionale?
Sono stato preso e messo lì dai suoi soci. Ettore era in Nuova Guinea e al suo rientro mi trovò nel suo ufficio. Con lui il rapporto si è costruito nel tempo. È stata una figura fondamentale per la mia crescita professionale, umana, culturale.

Memphis, 1984. Poster.
Architettura, design e grafica?
Ettore cercava ispirazione nelle zone periferiche delle culture dominanti. Ci dicevamo che forse la grafica più bella era quella diffusa nei bar di Sesto San Giovanni, dove il proprietario scriveva sulla vetrina con lo scotch “Qui si fanno i toast”. Cose rudimentali, insomma. Altro tratto tipicamente sottsassiano era l’esigenza di riempire gli spazi, non amava assolutamente i bianchi. Negli anni Ottanta, quando nacque il minimalismo, le persone cool stavano in case bianche e vuote, lui invece aveva bisogno di calore, di oggetti che lo proteggessero. Scrisse anche un piccolo saggio sulle case vuote. In realtà, voleva dare una dimensione domestica anche agli aeroporti, come quello di Malpensa, di cui ha curato gli interni.
Per te è stato un maestro?
Sì, aveva una grande apertura mentale che mi ha trasmesso anche semplicemente per simbiosi. Negli anni Ottanta ho iniziato a lavorare per lui, nel 1981 con Memphis, poi nel 1984 con l’agenzia di pubblicità Italiana di Comunicazione, una sorta di boutique creativa. All’epoca facevamo una rivista chiamata Terrazzo, una sorta di Cabana ante litteram, ma decisamente più intima. Eravamo in quattro: Ettore, Barbara Radice, la mia fidanzata di allora ed io. Ci trovavamo a casa di Ettore, bevevamo fiumi di vino e mettevamo a punto la rivista. C’era una grande energia creativa.
Una curiosità, ma è vero che Ettore prendeva funghetti e Lsd?
Negli anni Sessanta la cultura hippie non disdegnava il consumo di droghe. Si pensava che l’Lsd o il peyote potessero servire a trovare un altro io.
L’infinito. Tu ti drogavi?
Tutti abbiamo preso delle droghe. Condividevamo una cultura curiosa, il desiderio di trovare nuove forme creative ed esistenziali. Però questo succedeva prima, quando l’ho conosciuto io Sottsass non prendeva più nulla, aveva più di sessant’anni.
La droga ha segnato diverse stagioni creative.
Ho appena letto un libro sulla nascita dell’industria digitale nella Silicon Valley. Tutti questi ragazzi che si dedicavano all’informatica, come Steve Jobs o Bill Gates, vivevano una cultura di ribellione, si drogavano e vedevano nel computer lo strumento di accesso a tutte le informazioni del mondo. Ma il sistema capitalistico poi ha assorbito tutto, anche Internet. Le poche cose che resistono ancora sono i vari hacker, e Wikipedia.
Dato che oggi tutti lamentano la mancanza di idee, perché non tornare a prendere l’Lsd?
Potremmo proporlo al prossimo assessore alla Cultura di Milano: Lsd in tutte le scuole della città.
Non esageriamo, solo nelle scuole di design.
Un chirurgo creativo non andrebbe bene?

Catalogo A di Alessi, 2007. Cover.
Non credo funzionerebbe. Come sta il design?
In questo momento assistiamo al passaggio dal minimalismo al massimalismo. Il minimalismo è stato la cifra del design negli ultimi quindici anni. Tutto ha avuto inizio con gli oggetti minimal di Cappellini e si è affermato con Ikea, che fa buon design a bassissimo prezzo. Soprattutto se pensi che Ikea non parte dal prodotto, ma dal packaging.
Il consumismo ci seppellirà?
Sicuramente la nostra società non sopravvivrebbe se tutti comprassimo delle cose destinate a durare nel tempo. Come con la moda, il design deve proporre sempre qualcosa di nuovo. Ikea, in questo, è l’espressione del nostro tempo: rende accessibili a tutti dei prodotti da conservare e consumare in un tempo relativamente breve.
Ma il capitalismo non aveva fallito?
Tutt’altro. Come dice Thomas Piketty, stiamo tornando a una società ottocentesca, con un’aristocrazia di capitali che dispone di tutto senza dover lavorare, e il resto del mondo che non ha più accesso all’ascensore sociale. Oggi un giovane ha prospettive peggiori di quelle che ho avuto io. Questo fa sì che da un lato il design sarà sempre più democratico, e dall’altro si svilupperà un artigianato da pezzi unici, senza repliche e in edizione limitatissima.
Possiamo dare un consiglio?
Puntare all’autenticità. Qualcuno prima o poi lancerà un’Ikea italiana di qualità con prodotti economici che anziché durare solo cinque anni, ne dureranno quindici.
Facciamo una call, designer di tutta Italia unitevi.
La Brianza si sta attrezzando per questo tipo di competizione, sta cercando di fare il salto, conosco aziende che fanno sedie competitive con i prezzi di Ikea, ma di qualità migliore. Fra l’oggetto caro e quello economico c’è uno spazio immenso. Oggi o vai nella fascia alta o vai da Zara. Non c’è una via di mezzo.
A proposito, qual è il tuo rapporto con la moda?
È il mio settore preferito. Ci sono brand che spendono moltissimo per eventi che durano due o tre mesi. E intanto pensano già alla prossima iniziativa. Interessante lavorare sull’effimero, no?

Design Kaput, 2016, Galleria Luisa delle Piane, Milano.
La mostra Design Kaput allestita a Milano alla galleria Luisa delle Piane, inaugurata in occasione dell’ultimo MiArt e da poco terminata, verrà forse replicata a New York. In quell’occasione hai parlato di riappropriazione degli oggetti. Dimmi di più.
Non sono ancora sicuro di fare la mostra a New York, infatti non abbiamo ancora il nome della galleria. Se ci sarà, come spero, non si tratterà semplicemente di una replica della mostra fatta da Luisa delle Piane. Non è riappropriazione, ma appropriazione: in Design Kaput ho esposto sedie che non sono state designate da me, ma da Ola Wihlborg per Ikea. Su quelle sedute ho fatto dipingere a mano testi di canzoni che avevano a che fare con il sedere, elemento essenziale del corpo umano nell’uso di una sedia. Oltre alle sedie, ho fatto decorare anche un tavolo di Jean Prouvé prodotto da Vitra. L’unica cosa che ho progettato è il carattere tipografico, che ha come particolarità il fatto che ogni lettera occupa lo stesso spazio, un quadrato che riduce di poco la leggibilità, ma aumenta di molto l’effetto decorativo. Su una superficie grande diventa un tessuto con una trama regolare, come sulla carta da parati che copriva tutte le pareti e i soffitti dello spazio espositivo.
Che progetti hai per il futuro, Christoph?
Purtroppo, non so leggere il futuro, ma sono sicuro che mi riserverà ancora qualcosa di interessante.

Design Kaput, 2016. Galleria Luisa delle Piane, Milano.

Interni, n°600, Aprile 2010. Cover.

Terrazzo Magazine, n°1, autunno 1988.

Catalogo Magis, 2007. Cover.

TAR Magazine by Hans Peter Feldmann, 2012. Cover.